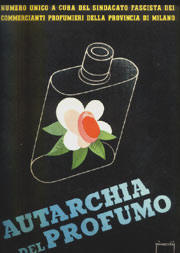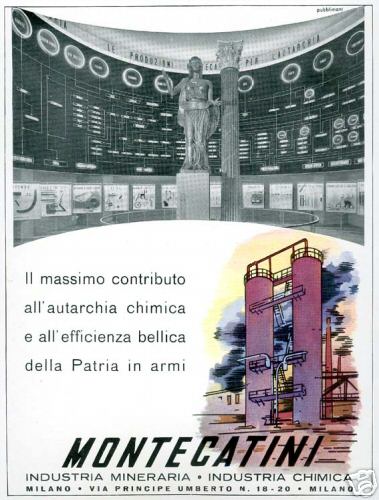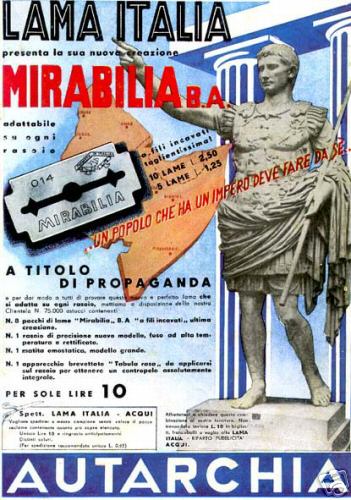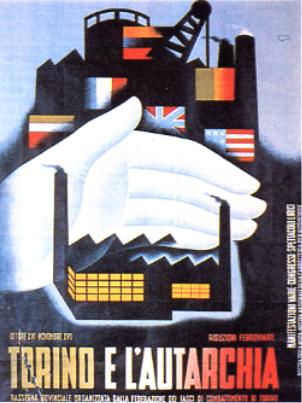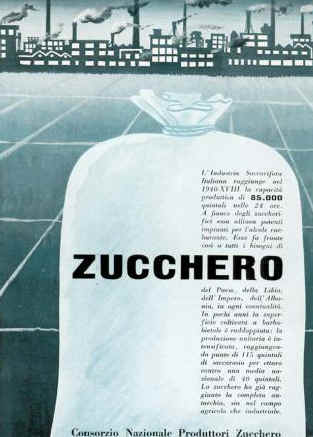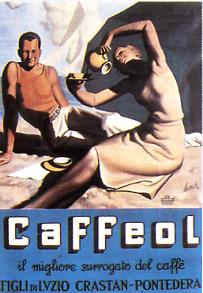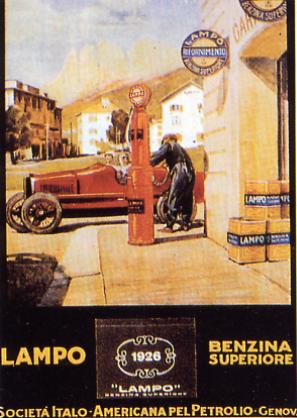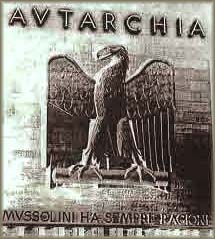|
|
|
L'AUTARCHIA
IN ITALIA
DURANTE
IL PERIODO FASCISTA
______________________
Autarchia, dal
greco Autarkeia
"bastare a se
stesso": parola che oggi è CADUTA IN DISUSO NELLA
TERMINOLOGIA ECONOMICA.
Come dire
"che un
Paese possa produrre all'interno tutto ciò di cui ha bisogno
rendendosi indipendente dall'estero"
_____________________
Alle soglie
della seconda guerra mondiale «autarchia», in Italia,
diventa una parola magica per un'economia
impoverita dal blocco internazionale che impedisce
l'approvvigionamento di materie prime ed energetiche. Risulta
difficile fare un quadro realistico, al di fuori di schemi
preconcetti e dell'uso che ne ha fatto finora la storiografia di
parte per la diffusa mancanza di notizie in merito.
Le sanzioni del 1935
seguite alla Guerra d'Etiopia, e il blocco delle materie prime,
colpirono la grande industria, i grandi monopoli; poi la media e la
piccola azienda ed infine i consumi. In tali critiche condizioni non
potevamo certo né produrre, né di conseguenza creare una domanda
interna o esportare a paesi che ci sanzionavano. I provvedimenti per
ridurre (far senza) l’import non rappresentarono un grande problema.
L'italiano medio non conosceva ancora il voluttuario, le case erano
modeste, il vestiario quello indispensabile e l'alimentazione nel
necessario. La necessità di fare da se, con quel che si aveva, venne
chiamata autarchia e fu la riscoperta del genio italiano. L'arte
secolare d’arrangiarsi, riveduta e corretta, tornò prepotentemente
di attualità. Non esportando formaggi, dal latte in esubero e quindi
dalla caseina si ricavò il lanital (un tipo di lana). Dalla
ginestra e dai fiocchi di canapa si ottenne un omonimo del cotone,
il cafioc. Dalla Canapa si otteneva già abbondantemente fibra
per sacchi e lenzuola (a dir la verità un poco ruvidi). Non
esportando vino questo fu trasformato in alcool (anche con
altri zuccherini) e i motori funzionavano discretamente con questo
combustibile. Sui giornali americani comparivano vignette satiriche
e affermazioni spesso gratuite del tipo.
"Sono
ritornati al fuoco delle fascine, basterà ancora una spinta e
torneranno ai carri con le ruote di pietra ".
Non avendo carbone, petrolio, gomma, acciaio, a breve termine questa
era la prospettiva comune per chi non sottostava alla loro sfida
economica, sostituitasi ormai a quella coloniale. L'Italia stava
quindi offrendo al mondo una immagine di miseria e di povertà di
risorse a discapito di tante altre ricchezze e virtù misconosciute.
Mancando la cellulosa, si riducevano le pagine dei giornali, e
perfino la carta bollata si porta a mezzo foglio. Mancava la gomma (
a dir la verità nel '42 la gomma mancava anche agli Usa) e il cuoio:
così gli italiani iniziarono a tagliare i vecchi copertoni e farne
suole da scarpe. Cercammo anche di far gomma nel tavoliere delle
Puglie con una pianta strana, il guayule, ma fu un fiasco. Arrivò
poi il capo e ordinò di fabbricare il cuoio con la cellulosa,
cartone compresso (con
questo si confezionarono aihmè anche gli scarponi per la Russia. La
guerra l'abbiamo cominciata con le fasce gambiere, con la lana che
non era lana, il cuoio Cuoital, miscela di cascami di cuoio sfibrati
con latex e vulcanizzati. Gli facevano concorrenza il Sapsa della
Pirelli (cascami di cuoio macinati e lattice di gomma) e il Coriacel
(cascami di cuoio, fibre vegetali e collanti..
etc.).
Ancor oggi se comprate una cinghia per pantaloni e spendete poco (me
l'hanno regalata) vuol dire che è fatta con questo cuoio autarchico.
Non parliamo poi di tante scarpe oggi a prezzi stracciati sui banchi
dei mercati, della medesima origine. Dalla famosa suola in Vibram
dei rocciatori del Montercervino scendeva il mito della scarpa
tecnologica, che non poteva essere a ragion di logica italiana; ma
Vibram sta per Vitale Bramani, l'italiano che l'aveva appunto
inventata nel 1936. A casa si indossavano sempre vestaglie e
camicie col collo rifatto con le parti basse, si guastavano e
riguastavano maglie vecchie. Le lamette da barba (americane di
sicurezza) da poco arrivate in Italia, conobbero subito il tramonto:
rispuntò così il rasoio che era stato messo da parte. Le ossa degli
animali si raccoglievano in appositi contenitori per bollirli e
saponificare. Con l'olio d'oliva non esportato si confezionavano le
saponette da toilette. Poi iniziarono a "nascondere" anche questo in
previsione della guerra e anche quello da bucato fu razionato con la
tessera. Il coloniale carcadè rimpiazza il te, la lignite il
carbone, la cicoria il caffè e il coniglio diventa pelliccia.
Dopo le riduzioni degli
anni di crisi (1929) stipendi e salari erano stati di nuovo
aumentati per adeguarli al carovita. Nelle città le comodità della
luce elettrica, dell'acqua corrente, del riscaldamento erano ora
molto più diffuse e sia nelle case nuove che vecchie ristrutturate,
si installavano bagni e docce. Su una popolazione di 42 milioni di
abitanti si contavano in quegli anni oltre 4 milioni di biciclette e
circa 200.000 motocicli e ciclomotori. Non più di 250.000 erano le
vetture private che circolavano: le più diffuse erano la Balilla e
la Topolino, lanciata proprio in quegli anni al prezzo di 8.900
lire. Ogni luogo di ritrovo era dotato di un apparecchio radio. Alla
radio d'altronde il fascismo affidava buona parte della sua
propaganda. Si stavano diffondendo anche gli apparecchi radio di
proprietà privata. Uno di tipo economico poteva costare circa 500
lire (una esagerazione, un mese di paga, per fare un confronto
quanto costa oggi un bel televisore a colori), altre piccole radio
si potevano montare in casa da soli. Un ciclomotore costava 1800
lire e una moto di 250 cc 5500 lire; (un pò care, ma erano state
progettate moto standard popolari più economiche); una macchina
fotografica 360 lire. Per le famiglie operaie, il cui livello di
vita restava modesto, esistevano spacci aziendali o cooperativi i
cui prezzi erano contenuti. Nelle campagne dell'Italia
centro-settentrionale le famiglie contadine avevano ottenuto
condizioni di vita migliori, ma le abitazioni erano ancora prive di
riscaldamento, (esisteva solo un grande camino), di acqua corrente,
(si usava un pozzo nel cortile) e di luce elettrica. Nel mezzogiorno
e in Sicilia molte famiglie delle campagne continuavano a vivere in
abitazioni cadenti, e potevano contare su paghe molto basse, del
tutto insufficienti a garantire la sopravvivenza per tutto l'anno.
Da qui l'importanza degli usi civici e delle attività complementari
e integrate. Molti contadini svolgevano così in Italia dividersi
lavori: erano al tempo stesso braccianti, fabbri, falegnami o
lavoravano alla manutenzione delle strade e delle linee ferroviarie.
Dopo il blocco dell’immigrazione in Usa (ma non per colpa delle
sanzioni a cui gli Usa non avevano neanche aderito) risalente agli
anni 20, si emigrava stagionalmente in Francia e Germania. Nella
paga giornaliera del bracciante agricolo erano spesso incluse una
razione di pane e di vino. I sabati liberi (riduzione produzione)
che si erano creati prima con la crisi del 29 poi con le sanzioni
saranno presto riempiti con distrazioni “politicamente controllate"
come il sabato fascista. Per i giovani delle scuole fu introdotta la
Premilitare, ginnastica e addestramento militare. L’Italia si era
riempita di palestre (con un uso diverso dall’attuale, non ci si
faceva ormoni, o si tirava su la pancia alle donne). Nell’ambito
regionale e provinciale si organizzavano i treni popolari per
portare la gente al mare, ai monti o al fiume (allora pulito), dove
venivano costruite colonie elioterapiche per bambini. Il dopolavoro
organizzato dal partito e dalla G.I.L (Gioventù italiana del
littorio) prevedeva locali di svago e ricreativi (compartecipazione
padronale), case del soldato (rispolvero della vecchia struttura
della grande guerra) e campeggi. Famosi i campi Dux all’aria aperta,
versione italiana degli Scout. Negli Stati Uniti, nello stesso
periodo, i datori di lavoro si erano armati per contrastare
eventuali proteste proletarie ed il paese galleggiava ancora fra
corruzione, malavita e protezionismo. In Francia il governo
socialista boccheggiava, in Spagna c'era la guerra civile, in
Inghilterra il marasma. Il mondo non brillava proprio di luce
divina. In campagna si cercava in maniera diversa di movimentare la
vita con le feste agricole: per la mietitura, variante della
Battaglia del Grano, per la vendemmia (Festa dell'uva), per il
carnevale etc. Per la gran parte queste feste sono sopravvissute nel
dopoguerra o rispolverate ora nell’ottica ambientale, populista ed
ecologista. Fra le realizzazioni sociali di questo periodo, ve ne
sono alcune di indubbio prestigio, come le strutture dell'ONMI
(Opera Nazionale Maternità e Infanzia). I tecnici industriali
italiani, gia visti in altro capitolo, erano tutti straordinari e
con idee rivoluzionarie a cui si concedeva una occasione in più per
realizzarle. Dall'ingegnere fino all'ultimo contadino ogni giorno ci
si poteva aspettare un nuovo prodotto, una nuova tecnica, una nuova
macchina, una nuova lavorazione; questo ingegno era ed è il “Made in
Italy”, lo stile italiano che da allora non è più tramontato.
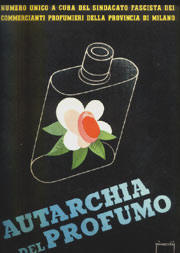
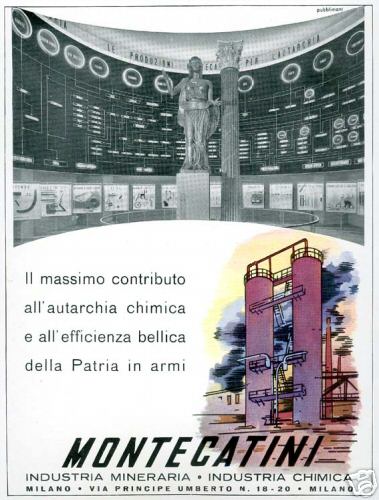
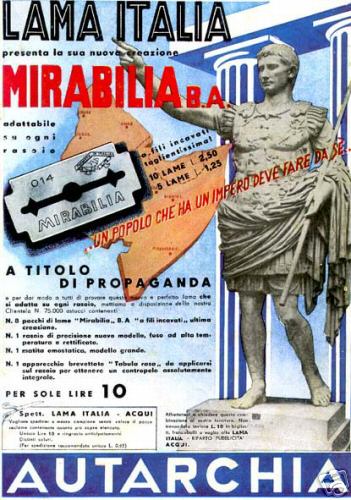
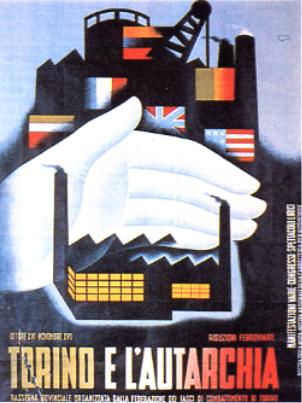 |
|
|
|
|
AUTOMOBILI A LEGNA O CARBONE:
a
gassogeno

In generale
un gassogeno o gasogeno è un qualunque dispositivo in grado di
produrre gas a partire da una massa solida. Ad esempio esistono
gassogeni a biomasse i quali raccolgono il gas prodotto da
escrementi e da altri materiali biologici in decomposizione, che può
poi essere utilizzato in diverse applicazioni, come il riscaldamento
domestico. I gassogeni più noti per ragioni storiche sono quelli a
gas povero, che consistono in particolari bruciatori nei quali al
combustibile solido (carbone, coke o semplicemente legna secca)
viene fornita una quantità insufficiente di ossigeno, cosa che
porta alla formazione di molecole di monossido di carbonio. Il
monossido di carbonio può ulteriormente essere ossidato portando
alla formazione di anidride carbonica. Il gas povero prodotto è
appunto una miscela di ossido di carbonio, anidride carbonica, azoto
e idrogeno, e si forma anche per effetto del vapore d'acqua che si
genera durante la combustione e attraversa il carbone incandescente
facendogli sprigionare una miscela detta gas d'acqua, che si unisce
agli altri prodotti della combustione (globalmente detti gas
d'aria). Il gas povero è dunque composto da gas d'acqua e gas
d'aria, e costituisce un combustibile economico ma con basso potere
calorifico.

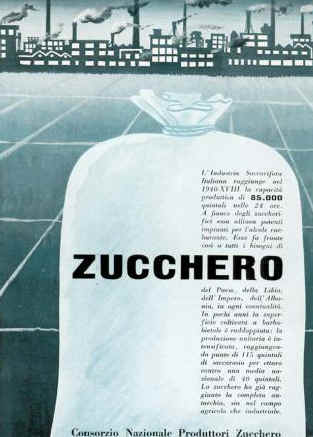
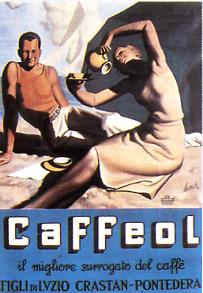
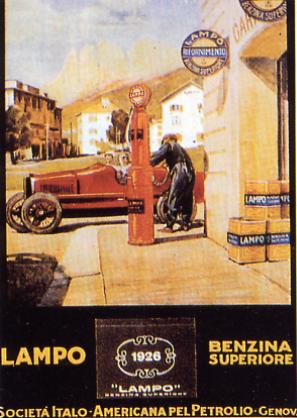
___________________
I TESSUTI
AUTARCHICI

L'ORBACE
Un
tessuto molto noto durante il periodo autarchico fu l’orbace. La
gente lo identifica anziché nel tessuto, spesso e volentieri nella foggia
e colore di quelle che allora erano le camicie nere (di servizio)
invernali dei gerarchi. L’orbace è un tessuto molto antico: si dice che
San Francesco arrivò in Sardegna quando mancavano una decina d’anni
alla sua morte, avvenuta nel 1226, indossando un saio d’orbace. Un
indumento certamente tipico delle tradizioni contadine italiane e
particolarmente adatto ai climi freddi. Con questo tessuto furono
confezionati il vestiario dei soldati romani, dei chierici nel periodo
medioevale, i pastrani degli ufficiali della marina italiana del secolo
scorso. L'orbace si otteneva selezionando i peli migliori, durante il
processo di cardatura: in questa fase venivano separati i peli più
lunghi, da riservare a questo particolare tessuto, e attorcigliati una
sola volta mentre i peli meno lunghi erano riservati alla trama. Una volta
tessuto, all'orbace veniva riservato un particolare trattamento, la
follatura. Questo procedimento, effettuato per calpestio oppure tramite
gualchiere, è un infeltrimento artificiale necessario a rendere il
tessuto impermeabile. Con lo stesso procedimento si fanno le famose
calzature russe contro il freddo i valenki (in feltro) che salvarono molti
dal congelamento. Nella follatura per calpestio il tessuto veniva posto a
terra, imbevuto di acqua calda e calpestato per ore; questa operazione,
che avveniva per strada o nei cortili ad opera di donne e banbini, poteva
essere effettuata anche mediante gualchiere, mazzuoli di legno azionati da
ruote idrauliche ( lungo i corsi d'acqua), che battevano il tessuto. La
Sardegna da sempre è il centro di questa attività e con questo tessuto
rigido e pungente si confeziona il tipico costume sardo (Sa
berritta (quasi un piccolo sacco), il corpetto e anche is
ragas, il gonnellino), le bisacce, le
mantelle, le coperte ed i rudimentali tappeti, tutti elementi ritenuti
indispensabili all'interno del mondo agro – pastorale.
__________________
IL
LANITAL
Nel
maggio del 1939, in occasione dell’ultima visita di Mussolini a Torino,
hanno luogo le «Seconde giornate dell'autarchia»: si respira già aria
di mobilitazione generale, la guerra è vicina. Con spirito ben differente
si svolgerà nel novembre del '42 il primo «Convegno tecnico
italo-germanico dell'autarchia». Metà delle relazioni tecniche sono a
firma di ingegneri tedeschi. Più del 70% dei laminatoi in Germania ormai
funzionano su cuscinetti di materia plastica: «Vinidur» e «Oppanol»
sono i nomi commerciali dei nuovi materiali a base di cloruro di
polivinile e su poli-isobutilene che trovano impiego anche nel nostro
Paese. Con il «Vinidur» si costruiscono tubi, condotti, recipienti per
l'industria chimica, carter per pompe. Per la prima volta si incomincia a
parlare di «materie abbinate». A un materiale si affidano le
funzioni di sostegno, a un altro quelle di resistenza all'usura o di
smorzamento delle vibrazioni. Autarchia non è soltanto sviluppo e
utilizzo di nuovi materiali - quasi un fai-da-te tecnologico - ma anche e
soprattutto la razionalizzazione della progettazione. Ma torniamo al
lanital. Soprattutto il tessile risente dell'ondata autarchica. Alla lana
si sostituisce il «Lanital» che dimostra caratteristiche di coibenza
termica migliore delle fibre artificiali alla viscosa e
cuproammoniacali.
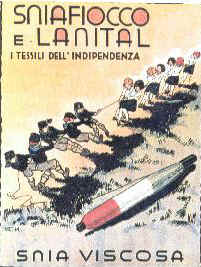
______________________
VAI
ALLE ALTRE IMMAGINI
DELL'AUTARCHIA FASCISTA

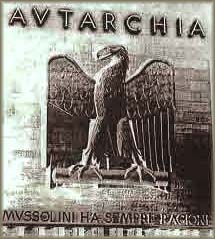
|